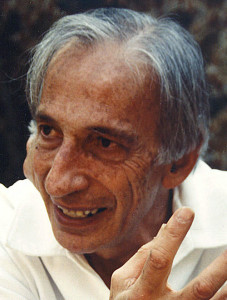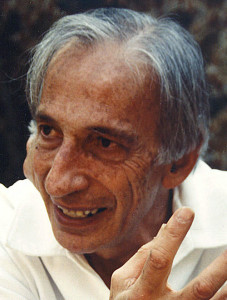
AG.RF.(redazione).24.02.2018
Il diritto alla disoccupazione utile.
“riverflash” – Attualmente ogni nuovo bisogno convalidato dalle professioni si traduce prima o poi in un diritto.
Tale diritto, una volta che sotto la pressione politica trova riconoscimento nella legge, dà luogo a nuove occupazioni e nuovi prodotti.
Ogni nuovo prodotto degrada un’attività con la quale la gente era stata fin allora capace di cavarsela da sola; ogni nuovo impiego rende illegittimo un lavoro sin lì svolto da non-occupati.
Il potere delle professioni di stabilire che cosa sia bene, giusto e da fare distorce nell’uomo ‘comune’ il desiderio, la voglia e la capacità di vivere secondo le proprie possibilità.
Quando tutti gli studenti attualmente iscritti nelle facoltà di giurisprudenza deg li Stati Uniti si saranno laureati, il numero degli esperti di diritto statunitensi aumenterà del cinquanta per cento circa.
Al servizio nazionale di assistenza sanitaria si affiancherà un analogo servizio di assistenza legale, man mano che l’assicurazione contro i procedimenti giudiziari diventerà indispensabile quanto lo è ora quella contro le malattie.
E una volta stabilito il diritto del cittadino a un avvocato, comporre un litigio all’osteria sarà considerato retrogrado e antisociale come lo è adesso partorire in casa.
Già ora il diritto riconosciuto a ogni cittadino di Detroit di vivere in un appartamento dove l’impianto elettrico sia stato installato da professionisti trasforma in trasgressore della legge chiunque si permetta di montare da sé una presa.
La perdita progressiva di tutta una serie di libertà d’essere utili altrove che in un ‘posto di lavoro’, o al di fuori del controllo professionale, anche se non ha un nome è una delle esperienze più penose che s’accompagnano alla povertà modernizzata.
Il privilegio più significativo d’una condizione sociale elevata potrebbe ormai identificarsi in qualche resto della libertà, sempre più negata alla maggioranza, di essere utili senza avere un impiego.
A furia di insistervi, il diritto del cittadino a essere assistito e approvvigionato si è quasi tramutato in diritto delle industrie e delle professioni a prendere la gente sotto la propria tutela, a rifornirla del loro prodotto e ad eliminare, con le loro prestazioni, quelle condizioni ambientali che rendono utili le attività non inquadrabili in una ‘occupazione’.
Si è così riusciti a paralizzare, per il momento, ogni lotta per un’equa distribuzione del tempo e della possibilità di essere utili a sé e agli altri al di fuori di un impiego o del servizio militare.
Il lavoro che si svolge al di fuori del ‘posto’ retribuito è malvisto quando non ignorato.
L’attività autonoma minaccia il livello dell’occupazione, genera devianza e falsa il P.N.L.: è quindi improprio chiamarla ‘Iavoro’.
Lavoro non vuol più dire sforzo o fatica, ma è quell’arcano fattore che, congiungendosi col capitale investito in un impianto, lo rende produttivo.
Non significa più la creazione di un valore percepito come tale dal lavoratore, ma più che altro un impiego, cioè un rapporto sociale.
Non avere un impiego significa passare il tempo in un triste ozio, e non essere liberi di fare cose utili a sé o al proprio vicino.
La donna attiva che manda avanti la casa, alleva i propri figli ed eventualmente ha cura di quelli degli altri è distinta dalla donna che “lavora”, ancorché il prodotto di tale lavoro possa essere inutile o dannoso.
L’attività, gli sforzi, le realizzazioni, i servizi che si esplicano al di fuori d i un lavoro gerarchico e che non sono misurabili secondo standard professionali costituiscono una minaccia per una società ad alta intensità di merci: la creazione di valori d’uso sottratti a un calcolo preciso pone infatti un limite non soltanto al bisogno di ulteriori merci, ma anche ai posti di lavoro che producono tali merci e alle buste-paga occorrenti per acquistarle.
Ciò che conta in una società ad alta intensità di mercato non è lo sforzo rivolto a produrre qualcosa che piaccia, o il piacere che deriva da tale sforzo, ma l’accoppiamento della forza lavoro col capitale.
Ciò che conta non è il conseguimento della soddisfazione che procura l’agire, ma la collocazione nel rapporto sociale che presiede alla produzione, cioè l’impiego, il posto, la carica, l’ufficio.
Nel Medioevo, quando non c’era salvezza al di fuori della Chiesa, riusciva arduo ai teologi spiegare come si regolasse Iddio con i pagani di costumi manifestamente virtuosi o santi; allo stesso modo nella società odierna nessuno sforzo è produttivo se non è fatto su ordine di un capo, e gli economisti non riescono a dar conto della palese utilità della gente che non agisce sotto il controllo di un’azienda, di un’organizzazione di volontari o di un campo di lavoro.
Il lavoro non è produttivo, rispettabile, degno di un cittadino se non quando è programmato, diretto e controllato da un rappresentante delle professioni, il quale garantisca che risponde in forma standardizzata a un bisogno riconosciuto.
In una società industriale avanzata diventa quasi impossibile cercare o anche soltanto immaginare di fare a meno di un impiego per dedicarsi a un lavoro autonomo e utile.
L’infrastruttura della società è combinata in maniera tale che solo l’impiego dà accesso agli strumenti di produzione, e questo monopolio della produzione di merci sulla creazione di valori d’uso non fa che consolidarsi quando la gestione passa allo Stato.
Solo con un certificato di abilitazione puoi insegnare a un bambino; solo in una clinica puoi rimettere a posto una gamba rotta.
Il lavoro domestico, l’artigianato, l’agricoltura di sussistenza, la tecnologia radicale, il mutuo insegnamento eccetera sono degradati ad attività per gli oziosi, per gli improduttivi, per i più diseredati o per i più ricchi.
La società che promuove un’intensa dipendenza dalle merci tramuta così i suoi disoccupati in poveri o in assistiti.
Nel 1945 per ogni americano mantenuto dalla previdenza sociale c’erano 35 lavora tori attivi; nel 1977, erano 32 i lavoratori occupati cui toccava mantenere uno di questi pensionati, dipendente a sua volta da una quantità di enti assistenziali che sarebbe stata inimmaginabile ai tempi di suo nonno.
Ormai il carattere di una società e della sua cultura dipenderà dalla condizione dei suoi non-occupati: saranno essi i cittadini produttivi più rappresentativi o saranno degli assistiti? Ancora una volta la scelta (la crisi) appare chiara: la società industriale avanzata può proseguire sulla scia del sogno integralista degli anni Sessanta: sempre più simile a una holding, può degenerare in un sistema di distribuzione che assegna parsimoniosamente un volume di beni e di posti in costante diminuzione e che addestra i suoi membri a consumi più standardizzati e a lavori più inutili.
E’ l’orientamento cui si ispirano le linee politiche della maggior parte dei governi, dalla Germania alla Cina, sia pure con una differenza di fondo nella gradazione: quanto più infatti il paese è ricco, tanto più sembra urgente contingentare l’accesso agli impieghi e impedire l’attività utile dei non-occupati suscettibile di recare pregiudizio all’occupazione.
Ovviamente è altrettanto possibile il contrario: cioè una società moderna nella quale i lavoratori frustrati si organizzino per proteggere la libertà di essere utili senza partecipare alle attività che danno luogo alla produzione di merci.
Ma, ancora una volta, questa alternativa sociale presuppone, da parte dell’uomo comune, una competenza nuova, razionale e cinica nei riguardi dell’imputazione professionale dei bisogni.
5. Nuove strategie delle professioni.
Il potere delle professioni è oggi messo in indubbio pericolo dalla crescente evidenza della loro controproduttività.
La gente incomincia ad accorgersi che la loro egemonia la spoglia del proprio diritto d’intervento nella cosa pubblica.
Il potere simbolico degli esperti che, col definire i bisogni, isteriliscono le capacità personali, è oggi considerato più pericoloso della loro potenza tecnica, che si limita a provvedere ai bisogni ch’essi creano.
Contemporaneamente, da più parti si sente invocare una legislazione che ci porti in una nuova era non più dominata dall'”ethos” professionale: si chiede che il sistema delle abilitazioni, oggi rilasciate dagli ordini professionali o dall’amministrazione, venga sostituito con un’investitura civica elettiva, più che essere semplicemente ritoccato con l’inclusione di rappresentanti dei consumatori negli organi che concedono le abilitazioni; si chiede un ammorbidimento delle prescrizioni vigenti nelle farmacie, nelle scuole e in altri pretenziosi supermercati; si chiede che vengano tutelate le libertà “produttive”; si chiede che sia riconosciuto il diritto di esercitare senza licenza; si chiedono strutture di servizio pubbliche che aiutino il cliente a valutare le prestazioni a pagamento dei professionisti privati.
Di fronte a queste minacce le principali istituzioni professionali ricorrono, ciascuna a suo modo, a tre fondamentali strategie per arginare l’erosione della loro legittimità e del loro potere.
L’autocritica della meretrice.
Il primo indirizzo strategico è rappresentato dal Club di Roma.
La Fiat, la Ford, la Volkswagen pagano economisti, ecologi e sociologi perché stabiliscano da quali produzioni le industrie dovrebbero astenersi affinché il sistema industriale funzioni meglio e si rafforzi.
Analogamente i medici del Club di Coo suggeriscono di rinunciare alla chirurgia, alle radiazioni e alla chemioterapia nella cura della maggior parte dei tumori, dato che di solito questi interventi non fanno che acuire e prolungare le sofferenze senza tuttavia accrescere la speranza di vita del malato.
Avvocati e dentisti promettono di vigilare come non mai sulla competenza, sulla correttezza e sulle parcelle dei propri colleghi.
Una variante di questo indirizzo si osserva in certi singoli professionisti o gruppi organizzati che, in America, contestano l’ordine degli avvocati, quello dei medici e talaltre potenze intermediarie del sistema.
Costoro si proclamano radicali perché 1) danno ai consumatori consigli che contrastano con gli interessi della maggioranza dei colleghi, 2) istruiscono i profani sul modo di comportarsi nei consigli d’amministrazione degli ospedali, delle università, degli enti di vigilanza, 3) hanno talvolta occasione di testimoniare, davanti a commissioni parlamentari, sull’inutilità di questa o quella misura proposta dalle professioni e richiesta dal pubblico.
Per esempio, in una provincia del Canada occidentale un gruppo di medici ha presentato una relazione su una ventina di interventi sanitari per i quali l’assemblea legislativa era orientata a stanziare maggiori fondi; si trattava di interventi costosi, e i medici hanno fatto rilevare che per di più erano anche assai dolorosi, che molti presentavano pericoli e che di nessuno di essi era provata l’efficacia.
Nell’occasione l’assemblea non ha voluto seguire il parere di questi medici ‘illuminati’, col risultato che il loro insuccesso, provvisoriamente, avvalora la credenza nella necessità di una tutela professionale dalla “hybris” professionale.
Il fatto che una professione eserciti una vigilanza di polizia sui propri membri è senz’altro utile per smascherare l’incompetenza smaccata, il macellaio o il puro ciarlatano.
Ma come è stato ampiamente dimostrato, la cosiddetta autodisciplina protegge gli inetti e cementa i vincoli di dipendenza del pubblico dalle loro prestazioni.
Il medico ‘critico’, l’avvocato ‘radicale’, l’architetto dedito alla creazione di quartieri autogestiti, sono professionisti che attirano clienti soffiandoli ai colleghi meno attenti di loro all’andamento della moda.
All’inizio le professioni liberali convinsero il pubblico della necessità delle loro prestazioni promettendo di aver cura della scolarizzazione, della formazione morale o dell’addestramento sul lavoro dei profani più poveri.
In seguito, divenute dominanti, le professioni si sono arrogate il pieno diritto di guidare il pubblico, e di menomarlo ancora di più, organizzandosi in club che ostentano la più acuta consapevolezza dei vincoli ecologici, economici e sociali.
Questo atteggiamento, se frena l’espansione del settore professionale, rafforza la soggezione del pubblico all’interno di esso.
L’idea che i professionisti abbiano un “diritto” di servire il pubblico è dunque d’origine recentissima.
La loro lotta per affermare e legittimare tale diritto corporativo è una delle minacce più pesanti che gravino sulla nostra società.
Il consorzio degli spacciatori.
La seconda strategia mira a organizzare e coordinare l’insieme delle prestazioni professionali in una maniera, si afferma, più aderente alla natura poliedrica dei problemi umani.
Questa tendenza cerca altresì di applicare nozioni mutuate dall’analisi dei sistemi e dalla ricerca operazionale allo scopo di fornire soluzioni globali valide per interi paesi.
Che cosa ciò significhi nella pratica lo si è potuto vedere in Canada.
Quattro anni fa il ministro canadese della sanità promosse una campagna diretta a convincere l’opinione pubblica che un aumento della spesa per i medici non avrebbe assolutamente inciso sui tassi nazionali di malattia e di mortalità.
Mise in rilievo che i decessi prematuri erano per la stragrande maggioranza dovuti a tre fattori: incidenti, soprattutto automobilistici; affezioni cardiache e cancro polmonare, che i medici notoriamente non sono in grado di guarire; e suicidi e omicidi, fenomeni che esulano dall’ambito medico.
Il ministro auspicava perciò un ridimensionamento delle prestazioni mediche e la ricerca di nuovi metodi per affrontare il problema della salute.
Il compito di proteggere, ristabilire o consolare coloro che sono resi infermi dalle deleterie condizioni ambientali e di vita tipiche del Canada odierno venne allora assunto da tutta una serie di professioni vecchie e nuove.
Gli architetti scoprirono la missione di migliorare la salute dei canadesi; la sorveglianza sui cani randagi risultò essere un problema interdipartimentale, che richiedeva nuovi specialisti.
Una nuova articolata biocrazia sottopose ad ancor più intenso controllo gli organismi dei canadesi, con una sistematicità che la vecchia iatrocrazia sarebbe stata incapace d’immaginare.
Lo slogan: Meglio spendere soldi per star bene che per pagare il medico quando si sta male si può ormai riconoscere per quello che è: il richiamo di nuove meretrici che vogliono attirare su di sé il denaro dei clienti.
Di una dinamica dello stesso tipo offre un esempio la pratica della medicina neg li Stati Uniti.
Qui l’attuazione di un sistema coordinato per la cura della salute divora somme sempre più gigantesche senza peraltro dimostrarsi particolarmente efficace.
Nel 1950 un lavoratore medio destinava annualmente all’assistenza sanitaria professionale meno di due settimane del proprio salario; nel 1976 il rapporto era salito aggirandosi tra le cinque e le sette settimane di retribuzione: quando si compra una nuova Ford si spende di più per l’igiene dei lavoratori che per il metal lo incorporato nell’auto.
Tuttavia, malgrado tanti provvedimenti e tante spese, la speranza di vita della popolazione maschile “adulta” non è aumentata in misura apprezzabile nel corso deg li ultimi cento anni.
Essa è inferiore a quella di molti paesi poveri e negli ultimi vent’anni non ha fatto che diminuire, lentamente ma costantemente.
Là dove il tasso di malattia è cambiato in meglio, il miglioramento è dovuto soprattutto all’adozione di un modo di vivere più sano, specie sotto l’aspetto dell’alimentazione.
In piccola misura, anche le vaccinazioni e il ricorso automatico a rimedi semplici come gli antibiotici, i contraccettivi e gli aspiratori Carman hanno contribuito alla diminuzione di certi stati morbosi.
Ma questi interventi non comportano la necessità di prestazioni professionali.
Non è attaccandosi ancora di più alla professione medica che la gente può star meglio in salute, e tuttavia molti medici cosiddetti ‘radicali’ invocano proprio una più estesa biocrazia.
Non si rendono conto, evidentemente, che pretendere di ‘risolvere i problemi’ della gente in maniera più ‘razionale’ significa agire al suo posto, spogliarla della decisione, sia pure nell’intento di assicurare una presunta maggiore uguaglianza.
La professionalizzazione del cliente.
La terza strategia intesa a far sopravvivere le professioni dominanti è la più recente delle mode radicali.
Mentre i profeti degli anni Sessanta sul limitare dell’Abbondanza vaticinavano un mirabile Sviluppo, questi fabbricanti di miti predicano l’autoassistenza del cliente professionalizzato.
Soltanto negli Stati Uniti, tra il 1965 e il 1976 sono usciti circa 2700 libri che insegnano come essere pazienti di se stessi in modo da aver bisogno del medico solo quando per lui ne valga la pena.
Alcuni testi consigliano un vero e proprio corso di addestramento all’automedicazione e vorrebbero che solo chi avesse superato il relativo esame finale fosse autorizzato a comprare aspirina e a somministrarla ai propri bambini.
Altri testi propongono che i pazienti professionalizzati beneficino di tariffe preferenziali negli ospedali e di sconti sui premi d’assicurazione.
Soltanto alle donne fornite di abilitazione a partorire in casa dovrebbe essere concesso di mettere al mondo i loro figli fuori d’un ospedale (anche perché, al caso, queste madri professioniste potrebbero rispondere esse stesse, di fronte alla legge, di eventuali incidenti dovuti a negligenza).
Secondo una proposta ‘radicale’ che mi è capitato di vedere, questa abilitazione al parto dovrebbe essere rilasciata da una commissione composta non da medici bensì da femministe.
Sotto l’insegna dell’autoassistenza c’è il sogno professionale di radicare in profondità qualunque gerarchia di bisogni.
Chi attualmente lo promuove è la nuova tribù degli esperti in autoassistenza, che hanno preso il posto degli esperti in sviluppo degli anni Sessanta.
Il loro obiettivo è la professionalizzazione universale del cliente.
Gli esperti americani dell’edilizia che lo scorso autunno hanno invaso Città del Messico sono un buon esempio di questa nuova crociata.
Un paio d’anni fa un professore d’architettura di Boston venne a passare le vacanze in Messico, e un mio amico messicano lo portò a vedere la nuova città che, in poco più d’un decennio, è cresciuta dietro l’aeroporto della capitale.
Questa comunità, che prima era un piccolo agglomerato di capanne, si è improvvisamente sviluppata fino a contare tre volte più abitanti di Cambridge del Massachusetts.
Il mio amico, pure lui architetto, voleva mostrare al collega i mille esempi dell’ingegnosità contadina in fatto di disegni, strutture, e utilizzazione dei rifiuti, tutti esempi non contemplati nei manuali e quindi non derivati da essi.
Naturalmente, alla vista di quelle brillanti invenzioni con cui dei dilettanti sono riusciti a far funzionare una borgata di due milioni di abitanti, il collega bostoniano scattò centinaia di rullini di pellicola.
Le fotografie furono debitamente studiate a Cambridge; e l’anno non era ancora finito che già specialisti statunitensi appena sfornati dai corsi di architettura comunitaria si affaccendavano a insegnare alla gente di Ciudad Netzahualcoyotl quali fossero i suoi problemi, i suoi bisogni e le relative soluzioni.
6. L’ethos post-professionale.
L’opposto della carenza, del bisogno e della povertà definiti col metro delle professioni è la sussistenza di tipo moderno.
Il termine ‘economia di sussistenza’ è oggi generalmente usato per indicare una forma di sopravvivenza di gruppo che è marginale quanto alla dipendenza dal mercato, e nella quale la gente produce ciò che utilizza per mezzo di strumenti tradizionali e nel quadro di un’organizzazione sociale ereditata che spesso, tramandandosi, non subisce alcuna revisione.
Io propongo di recuperare questo termine in un senso moderno, chiamando ‘sussistenza moderna’ il modo di vita predominante in un’economia post-industriale in cui la gente sia riuscita a ridurre la propria dipendenza dal mercato, e ci sia arrivata proteggendo, con mezzi politici, un’infrastruttura dove le tecniche e gli strumenti servano in primo luogo a creare valori d’uso non quantificati né quantificabili dai fabbricanti professionali di bisogni.
Ho sviluppato altrove (nel libro “La convivialità”) una teoria di questi strumenti, proponendo di chiamare ‘strumento conviviale’ ogni attrezzatura orientata verso la produzione di valori d’uso.
E ho anche mostrato come l’inverso della progressiva povertà modernizzata sia un’austerità conviviale risultante da una scelta politica che salvaguardi la libertà e l’equità nell’uso di tali strumenti.
Riattrezzare la società contemporanea con strumenti conviviali e non più industriali comporta uno spostamento d’accento nella nostra lotta per la giustizia sociale; comporta una subordinazione, in forme da trovare, della giustizia distributiva alla giustizia partecipativa.
In una società industriale, gli individui sono educati alla massima specializzazione.
Diventano impotenti a formulare o a soddisfare i propri bisogni.
Dipendono, quanto ai beni di consumo, da gestori che firmano la prescrizione per loro.
Il diritto alla diagnosi del bisogno, alla prescrizione della terapia e, in genere, alla distribuzione dei beni predomina nell’etica come nella politica e nella legislazione.
Questo primato riconosciuto al diritto di vedersi attribuire delle necessità riduce a un fragile lusso la libertà di imparare, di guarire, di muoversi autonomamente.
In una società conviviale avverrebbe il contrario.
La tutela dell’equità nell’esercizio delle libertà personali sarebbe la preoccupazione dominante di una società fondata su una tecnologia radicale, dove la scienza e la tecnica fossero poste al servizio di una più efficace creazione di valore d’uso.
Ovviamente una simile libertà non avrebbe alcun senso se non fosse basata su un uguale diritto di accesso alle materie prime, agli strumenti ed ai servizi comuni.
Come il cibo, il combustibile, l’aria pura o lo spazio vitale, così gli attrezzi o i posti di lavoro non possono essere distribuiti equamente se non razionandoli senza riguardo per i bisogni attribuiti, cioè stabilendo un uguale limite massimo per giovani e vecchi, per l’handicappato come per il presidente.
Una società improntata alla tutela di un’uguale disponibilità di strumenti moderni ed efficaci per l’esercizio delle libertà produttive non può esistere se i beni e le risorse su cui poggia l’esercizio di tali libertà non sono ugualmente ripartiti fra tutti.
Nota bibliografica di Antonio Airoldi.
Nella nostra essenziale bibliografia abbiamo privilegiato i libri di Illich e i suoi saggi inclusi in volumi collettanei, escludendo i contributi apparsi su riviste la cui reperibilità è spesso problematica.
Tra questi ultimi, comunque, sono numerosi quelli pubblicati, nella loro redazione definitiva, nelle principali opere di Illich qui presentate.
Nelle note si segnalano invece eventuali lavori preparatori, altre versioni o edizioni non autorizzate di saggi di Illich disponibili in lingua italiana, così da consentire al lettore un orientamento bibliografico più sicuro.
“The Church, Change and Development“, a cura di F. Eycanger, intr. di J. P. Morton, Urban Center Training Press, Chicago, 1970. (Quattro dei saggi qui inclusi, compreso quello che dà il titolo al libro, appaiono anche in “Celebration of Awareness”, vedi “infra”.) Raccolta di articoli e interventi scritti o pronunciati ne gli anni Sessanta (alcuni già abbozzati negli anni Cinquanta), che hanno per oggetto la Chiesa e i suoi compiti nel contesto dei processi di trasformazione dell’epoca moderna.
L’annuncio dell’Evangelo e la celebrazione di autentiche esperienze di cambiamento sono indicati come la vocazione specifica di una Chiesa che riscopre la gratuità della fede e rinuncia in campo sociale al potere di supplire le istituzioni secolari. …
Illich costruisce una grammatica in cui il “silenzio” appare come la forma suprema di comunicazione, la “povertà” come il veicolo per l’atto più significativo e ricco, e la “mancanza di potere” come condizione per esercitare una guida autorevole; egli costruisce un linguaggio in cui si afferma l’autonomia dello “spontaneo” e del “sorprendente” nei confronti del pianificato, del “ludico” in opposizione all’utile, e del “gratuito” rispetto al voluto (J. P. Morton).
“Celebration of Awareness. A Call for Institutional Revolution“, Doubleday E Co., Garden City, New York, 1970. Trad. it. “Rovesciare le istituzioni.
Un ‘messaggio’ o una ‘sfida’”, intr. di E. Fromm, Armando, Roma, 1973.
Il libro è una raccolta di articoli scritti tra il 1956 e il 1970, alcuni dei quali espressione significativa dell’autocritica degli anni Sessanta, che ha portato Illich a radicalizzare la sua denuncia sociale.
La riflessione spazia dai temi di natura religiosa (meditazioni sul silenzio, interventi sul futuro del clero, sul carattere coloniale delle missioni e sul rapporto Chiesa-potere (1)) alle problematiche d’interesse civile e sociale (il Vietnam, la violenza e l’integrazione razziale negli Usa, le politiche di controllo delle nascite, gli aiuti allo sviluppo, la funzione della scuola nei paesi poveri).
Ogni capitolo di questo volume è il segno di un mio tentativo di mettere in discussione la natura di qualche certezza acquisita.
Ciascuno di essi, quindi, denuncia un inganno, l’inganno insito in questa o quel la istituzione.
Sono le istituzioni che creano certezza e quando vengono prese sul serio queste certezze rendono il cuore insensibile e imprigionano l’immaginazione.
“Deschooling Society“, Harper & Row, New York, 1971.
Trad. it. “Descolarizzare la società”, intr. di H. von Hentig, Mondadori, Milano, 1972 (2).
Un testo fondamentale, che è stato al centro del dibattito internazionale sulle politiche educative negli anni Settanta, ma che nulla concede all”illusione pedagogica’.
Il “leit-motiv” del libro è l’ipotesi che la crescente produzione industriale di servizi, di cui la scuola è solo l’esempio paradigmatico, comporti effetti collaterali negativi, paragonabili a quelli della sovrapproduzione di merci.
Lungi dal realizzare l’eguaglianza delle opportunità che promette, la scuola infatti riproduce e consolida la stratificazione sociale e funge da moderno cerimoniale di iniziazione alla società dei consumi.
Essa appare come un grande rituale mitopoietico, generatore di miti che rendono tollerabile la sua controproduttività paradossale, ovvero la paralisi dell’apprendimento che il monopolio scolastico produce inevitabilmente.
La descolarizzazione, come movimento già in atto inteso a porre un limite all’istituzionalizzazione dei valori, riguarda non solo l’istruzione, ma il tessuto complessivo di una società che trasforma i valori in prodotti da consumare in dosi sempre maggiori.
Il successo di tale movimento dipenderà dalla scelta preferenziale di una cornice istituzionale conviviale che educhi costantemente all’azione e all’autonomia.
L’alternativa alla dipendenza dalle scuole non è dunque lo stanziamento di fondi pubblici per qualche nuovo congegno che ‘faccia’ imparare, ma la creazione di un nuovo tipo di rapporto educativo tra l’uomo e il suo ambiente.
“Tools for Conviviality“, Harper & Row, New York, 1973.
Trad. it. (dall’edizione francese) “La convivialità”, Mondadori, Milano, 1974 e red edizioni , Como, 1993 (3).
Il testo, un classico dell’ecologia politica degli anni Settanta, fornisce una metodologia per l’analisi multidimensionale del sovrasviluppo industriale.
Oggetto dell’indagine è il monopolio radicale esercitato dal modo di produzione industriale, che distrugge i valori d’uso dell’ambiente fisico, sociale e culturale, imponendo una crescente dipendenza dalle merci e dai servizi industriali.
Il concetto chiave attorno al quale si polarizza l’analisi di Illich è quello di “strumento”, che designa il semplice utensile come i complessi apparati burocrati ci e industriali.
Superate certe soglie critiche, lo strumento finisce per veicolare dei privilegi di classe, così da cessare nella sua materialità di essere politicamente indifferente e da imporre relazioni sociali oppressive.
L’obiettivo è fornire una griglia di analisi che consenta di definire le dimensioni ottimali degli strumenti, la cui crescita ipertrofica minaccia l’equilibrio della vita in diversi settori cruciali, dalla biosfera al diritto alla storia.
L’alternativa auspicata è una politica conviviale che persegua i valori della vitalità, dell’equità e dell’autonomia creatrice e ponga dei limiti alla crescita degli strumenti manipolatori.
Non propongo una utopia normativa, ma i presupposti formali di una procedura che permetta a qualunque collettività di scegliersi continuamente la propria utopia realizzabile.
La convivialità è multiforme: si basa non sul dogma, ma sull’anatema delle condizioni che la renderebbero impossibile.
“Energy and Equity“, Calder & Boyars, Londra, 1974.
Trad. it. “Energia ed equità”, in “Per una storia dei bisogni”, pagine 163-207 (vedi “infra”) (4).
Attraverso l’analisi del sistema dei trasporti vengono demistificate le illusioni che si annidano nell’espressione ‘crisi energetica’.
Secondo l’autore, elevate quantità di energia degradano le relazioni sociali con la stessa ineluttabilità con cui distruggono l’ambiente fisico.
Una politica di bassi consumi energetici può invece favorire molteplici stili di vita caratterizzati da alti livelli di equità.
Spetta al processo politico democratico stabilire quei limiti all’uso dell’energia che promuovano un equilibrio positivo tra strumenti industriali e strumenti conviviali.
Al di là della sottoattrezzatura e della sovraindustrializzazione, c’è posto per il mondo dell’efficacia post-industriale, dove il modo di produzione industriale è complementare ad altre forme autonome di produzione.
C’è posto, in altre parole, per un mondo di maturità tecnologica.
Per quanto riguarda il traffico, è il mondo di coloro che hanno triplicato le dimensioni del loro orizzonte quotidiano salendo su una bicicletta.
“Limits to Medicine.” Medical Nemesis: the Expropriation of Health”, Marion Boyars, Londra, 1976.
Trad. it. “Nemesi medica. L’espropriazione della salute”, Mondadori, Milano, 1977 e red edizioni, Como, 1991.
Salute, apprendimento e mobilità personale sono ottimali quando la produzione industriale di servizi integra, rendendole più efficaci, le capacità degli individui di guarire, imparare, spostarsi.
Esse invece declinano quando, superati dei limiti critici, la tutela istituzionalizzata distrugge le condizioni ambientali e culturali necessarie per la produzione di valori d’uso.
Da questo punto di vista la ‘nemesi medica’, la minaccia per la salute come tragico effetto della crescita dell’organizzazione sanitaria, è solo un aspetto della più generale ‘nemesi industriale’, cioè della nocività del sovrasviluppo industriale.
Le conseguenze dannose del sistema medico, definite col termine di “iatrogenesi”, non si manifestano semplicemente a livello clinico con terapie menomanti, ma anche a livello sociale con la medicalizzazione della vita come surrogato della lotta politica per un ambiente salubre e, più profondamente, a livello culturale con l’indebolimento della capacità personale di far fronte al dolore, alla sofferenza e alla morte.
Il rimedio all’epidemia iatrogena non può essere delegato ai professionisti: scopo del libro è dimostrare che solo un programma politico diretto a limitare la gestione professionale della sanità può permettere alla gente di recuperare la propria capacità di salvaguardare la salute, e che tale programma è parte integrante di una critica e limitazione sociale del modo di produzione industriale (5).
“Toward a History of Needs“, Pantheon Books, New York, 1978.
Trad. it. “Per una storia dei bisogni”, Mondadori, Milano, 1981 (6).
I saggi qui raccolti (scritti tra il 1969 e il 1977) condensano, e concludono, un decennio di ricerche sul modo di produzione industriale e sulle ‘internalità’ negative di varie istituzioni moderne (il sistema dei trasporti che fa sprecare tempo, la sanità che produce malati, la scuola che istupidisce) (7).
Ogni articolo descrive, da angolature differenti, quel fenomeno paradossale che è la modernizzazione della povertà, cioè l’impotenza del cittadino ad agire autonomamente a causa della sua crescente dipendenza da merci e servizi industriali il cui bisogno è indotto da una casta di esperti.
In ognuno di questi cinque saggi, ho cercato di dare un contributo al processo politico che deve portare i cittadini a riconoscere le soglie socialmente cruciali dell’arricchimento e a tradurle in tetti o limiti validi per l’intera società.
“El derecho al desempleo creador“, in ‘Tecno-Politica’, Doc.78/11, Cuernavaca, Mexico, 1978.
Trad. it. “Il diritto alla disoccupazione creativa“, in C.AB.AU. (Collettivo per un abitare autogestito), a cura di “Autocostruzione e tecnologie conviviali”, Clueb, Bologna, 1980, pagine 16-37.
Un’analisi storico-semantica delle ambiguità su cui si regge l’identificazione moderna dell’attività lavorativa col lavoro salariato.
Solo dissipando questo tabù si potrà promuovere un tipo di sviluppo in cui sia ridotto e distribuito equamente il volume di impieghi, e in cui il progresso tecnico garantisca il diritto di tutti a quelle attività utili e efficaci, orientate ai valori d’uso, che Illich indica con l’espressione ‘disoccupazione creativa’.
Secondo il nostro modo di vedere, una nuova tecnica rappresenta un progresso quando e solo quando per mezzo di essa è possibile stabilire un maggiore equilibrio fra due tipi di giustizia complementari: da un lato l’eguaglianza di accesso ai prodotti e alle risorse della società (giustizia distributiva dei beni scarsi), e dall’altro, esattamente con la stessa gerarchia, un ambito di autonomia uguale per tutti nella creazione di valori d’uso (giustizia partecipativa).
“Vernacular Values“, in ‘Resurgence’, n. 72, febbraio 1979, e n. 73, marzo-aprile 1979.
Trad. it. “Il valore vernacolare“, in C.AB.AU. (Collettivo per un abitare autogestito) “Il potere di abitare”, pres. di I. Illich, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1982.
Vernacolare è ciò che si oppone a quanto riceve valore dal mercato e i valori vernacolari possono fiorire in molteplici modi qualora vi siano strutture istituzionali che si pongano al loro servizio.
Optare per una tecnologia vernacolare non vuol dire che non vogliamo pensare a migliorare e rendere più appropriata, efficace ed efficiente la produzione di merci, ma che vogliamo muoverci verso una società che pone al centro delle sue preoccupazioni politiche, legali, etiche, lo sviluppo del dominio vernacolare e considera i beni di scambio desiderabili solo se strumenti tramite i quali si possa espandere ulteriormente l’area vernacolare.
“Shadow Work“, Marion Boyars, Londra-Boston, 1981.
Trad. it. (dall’edizione tedesca) “Lavoro ombra”, Mondadori, Milano 1985.
Il libro comprende vari saggi, scritti tra il 1978 e il 1981 che hanno per tema i “commons” (comunanze, usi civici), di cui viene analizzata la soppressione come presupposto storico della formazione del regime della scarsità (articoli sulla lingua, sul lavoro e sull’educazione), e di cui si ritiene possibile un moderno recupero (in particolare negli articoli sulla dimensione comune della pace e della politica).
Il saggio che dà il titolo alla raccolta descrive il processo che ha portato, tra il diciassettesimo e il diciannovesimo secolo, all’eliminazione progressiva dei valori d’uso comune dell’ambiente, in cui si radicavano le attività di sussistenza.
Come conseguenza, il lavoro salariato ha subito una metamorfosi da fonte di fatica e sofferenza a fonte di ogni valore, e ha fatto la sua comparsa un nuovo genere di lavoro, rappresentato dalla schiavitù della donna nella sfera domestica: il lavoro-ombra, complemento non retribuito del lavoro salariato.
In questa prospettiva, lo sviluppo industriale può essere letto come la storia del progressivo allargamento dell’economia-ombra, a scapito di attività ‘vernacolari’ , orientate ai valori d’uso.
Inesorabilmente, quest’ombra si allarga e si allunga sulla scia della crescita economica, coprendo una porzione sempre più vasta della vita anche degli uomini: il lavoro casalingo è semplicemente la zona su cui l’ombra si è posata per prima.
L’esistenza nella società industriale, dove la disoccupazione è in continuo aumento, sempre più si svolgerà nell’ambito di quest’ombra.
“Gender“, Pantheon Books, New York, 1982 e Marion Boyars, Londra – New York, 1983.
Trad. it. “Il genere e il sesso”, Mondadori, Milano, 1984.
Il libro è un ulteriore capitolo della storia della formazione del dominio della scarsità, ma anche un’autocritica rispetto alla prospettiva “unisex” dei lavori precedenti.
Sesso e genere sono ‘tipi ideali’ che designano realtà sociali duali eterogenee.
Il concetto di genere indica una differenza di comportamenti tipica di tutte le culture vernacolari, una complementarità ambigua e asimmetrica tra uomini e donne che si può esprimere solo con un linguaggio metaforico.
Il genere distingue i luoghi, i tempi, gli utensili, i compiti, i modi di parlare, i gesti e le percezioni associati agli uomini da quelli associati alle donne.
Il sesso sociale, che subentra all’esperienza del genere con il declino delle comunità vernacolari, è una polarizzazione delle caratteristiche comuni a un essere umano neutro, il soggetto dell’economia come scienza dei valori scarsi.
La scomparsa del genere è perciò considerata la condizione decisiva dell’ascesa del capitalismo e di un modo di vivere che dipende da merci prodotte industrialmente.
A farne le spese sarebbero in primo luogo le donne, relegate al ruolo di ‘secondo sesso’ nella società industriale e condannate a un “apartheid” economico senza precedenti.
“Schule ins Museum: Phaidros und die Folgen”, introduzione di R. K.
Rettenbeck e L. Kuchenbuch, Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 1984.
Sulla transizione dalle culture orali a quelle alfabetizzate.
Un’anticipazione delle tematiche oggetto di più ampia trattazione in “ABC: The Alphabetization of the Popular Mind” (vedi “infra”).
L’indagine di Illich sulla scrittura nell’antichità e nel Medio Evo offre un valido punto di riferimento per ripensare la storia della scuola…
La scuola apparirà così quale concreto e metodico epifenomeno della scrittura (R. K. Rettenbeck e L. Kuchenbuch).
“Einfhrung in die Kulturgeschichte der Knappeit”, in S. H. Pfrtner (a cura di) ” Wider den Turmbau zu Babel. Disput mit Ivan Illich”, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1985.
Esamina le trasformazioni dell’ideale dell’”homo viator” (il pellegrino) nel dodicesimo secolo, allo scopo di mettere in luce, nel contesto della storia cultura le della scarsità, la singolarità dell’individualismo possessivo della modernità.
“H2O and the Waters of Forgetfulness“, Marion Boyars, Londra – New York, 1986.
Trad. it. “H2O e le acque dell’oblio”, Macro Edizioni, Umbertide (PG), 1988.
Anche la ‘materia’ o ‘sostanza’ profonda dell’immaginario è una creazione sociale “sui generis”, la cui storia può essere oggetto di indagine.
Attraverso un “excursus” che attinge alla mitologia, alla storia delle mentalità e all’antropologia, il libro esamina la ridefinizione parallela delle acque e del lo spazio urbani, le ‘materie’ costitutive della città.
L’indagine di Illich mette a fuoco i mutamenti nella percezione dell’acqua e dei corpi verificatisi nell’Europa moderna con il diffondersi delle pratiche igieniche, un processo che culmina con l’adozione del wc e la trasformazione dei fertili escrementi in ‘rifiuti’ immessi nel ciclo delle acque urbane.
Lo storico divenuto sensibile alla storicità della ‘materia’ scopre così che l’acqua, da ‘sostanza’ inesauribile che alimentava l’immaginazione, i sogni e i miti, è divenuta H2O, un fluido industriale inquinato, dalla cui depurazione dipende la sopravvivenza umana.
H2O e acqua sono diventate antagoniste: l’H2O è una creazione sociale dei tempi moderni, una risorsa che è scarsa e che richiede una gestione tecnica.
E’ un fluido che ha perso il potere di rispecchiare l’acqua dei sogni.
“La metamorfosi del pagano, ovvero l’intolleranza terapeutica”, in P. C. Bori (a cura di) “L’intolleranza: uguali e diversi nella storia“, Il Mulino, Bol ogna, 1986, pagine 219-226.
Le forme più brutali di intolleranza della nostra società devono essere viste come manifestazioni estreme di un atteggiamento diffuso: la manipolazione dell’altro, operata in vista del suo bene dalle professioni assistenziali.
Questa intolleranza terapeutica, parente del moderno razzismo, fa la sua comparsa nel Novecento, ma presuppone una percezione della diversità come difetto da eliminare (il pagano come prototipo dell’altro) che risale all’istituzionalizzarsi del cristianesimo.
(Con B. Sanders) “ABC: The Alphabetization of the Popular Mind”, Marion Boyars, Londra-New York, 1988.
Che ne è dell’alfabetizzazione nella società dell’elettronica e dei computer? Con l’ occhio rivolto al presente e ai suoi mutamenti, gli autori ci accompagnano in un affascinante percorso storico tra oralità e scrittura, mostrandoci le conseguenze del processo di alfabetizzazione sulla mentalità della gente comune nel Medio Evo.
In questa luce, molte categorie fondamentali della cultura occidentale (la distinzione di pensiero e linguaggio, l’idea di testo e di traduzione, la memoria come deposito e il sé modellato sull’immagine del testo) appaiono come costrutti storici, sviluppatisi parallelamente alla diffusione delle tecniche di scrittura.
La struttura mentale alfabetizzata, di cui viene descritta la genesi storica, sarebbe attualmente minacciata, secondo gli autori, dalla crescente equiparazione delle lettere a “bit” (unità di messaggio), che riduce il linguaggio a semplice codice.
Non è nostra intenzione opporre una visione paranoica delle forme odierne di comunicazione all’utopia romantica di un vernacolo vergine che rispecchia verità di fatto.
Piuttosto, l’indagine conduce alla scoperta di un paradosso: l’alfabetizzazione, per quanto dannosi siano stati per i nostri contemporanei gli effetti collaterali della sua obbligatorietà, rimane ancora l’unico baluardo contro la dissoluzione del linguaggio in un mero sistema di informazioni.
“In the Mirror of the Past“, Marion Boyars, Londra – New York, 1992.
Trad. it. “Nello specchio del passato”, red edizioni, Como, 1992.
Raccolta di saggi e interventi scritti tra il 1978 e il 1990, il cui filo rosso è costituito dallo scavo archeologico interessato a disvelare le radici storiche dei luoghi comuni della modernità.
Solo nello specchio del passato risulta infatti possibile riconoscere la radical e alterità della topologia mentale del ventesimo secolo e divenire consapevoli dei suoi assiomi generativi, che normalmente rimangono oltre l’orizzonte dell’attenzione dei contemporanei.
Al termine di questo viaggio a ritroso molte certezze costitutive del nostro paesaggio reale e mentale perdono la loro presunta ovvietà.
L’economia come fonte del valore, la pace come equilibrio tra potenze economiche, la necessità di una ‘sfera educativa’, la cura di sé, l’ideologia cibernetica, il linguaggio come forma di ‘comunicazione’ e persino la ‘vita’ ci appaiono allora come costrutti sociali che, avendo un inizio, possono anche avere una fine.
Affrontando questi temi, riflessi provocatoriamente nello specchio del passato, Illich ci stimola a pensare il presente e il futuro con una consapevolezza nuova: La mia è la ricerca di una politica dell’autolimitazione, grazie alla quale, anche oltre gli orizzonti dell’attuale cultura, il desiderio possa fiorire e i bisogni declinare.
“Needs“, in W. Sachs (a cura di) “The Development Dictionary”, Zed Books, Londra, 1992, pagine 88-101.
Nell’arco di una generazione il discorso dello sviluppo ha prodotto una metamorfosi della natura umana, trasformando “homo sapiens” in “homo miserabilis”, l’uomo dipendente dai bisogni di merci e servizi industriali e svincolato dalle necessità culturalmente definite.
Il saggio traccia una fenomenologia dei bisogni come certezza sociale indiscussa della nostra epoca e ne ricostruisce la genesi storica e gli slittamenti di significato verificatisi negli ultimi quattro decenni, richiamando l’attenzione sul la loro attuale insidiosa riconcettualizzazione nel contesto delle teorie sistemiche.
Noi ci troviamo sulla soglia di una transizione, finora non avvertita, da una consapevolezza politica basata sulle idee di progresso, crescita e sviluppo, radicata nei sogni dell’Illuminismo, ad una nuova consapevolezza, ancora priva di un termine che la denomini, definita da dispositivi di controllo che assicurano un ‘sistema sostenibile’ di soddisfazione dei bisogni.
“Ivan Illich in Conversation“, a cura di D. Cayley, House of Anansi Press, Don Mills (On., Canada), 1992.
Trad. it. “Conversazioni con Ivan Illich“, intr. di F. La Cecla, Elèuthera, Milano, 1994.
Più che un’intervista, un dialogo tra Illich e il giornalista canadese Cayley che consente di ripercorrere l’itinerario intellettuale di Illich dalla demistificazione delle ‘vacche sacre’ dello sviluppo degli anni Sessanta e Settanta (la scuola in primo luogo) fino alla ridicolizzazione dei feticci degli anni Novanta (la’vita’, il “management” ecologico del pianeta eccetera).
Un itinerario niente affatto lineare, contrassegnato da svolte e profonde autocritiche, da approfondimenti a spirale, il cui esito attuale è l’affinarsi degli strumenti di analisi storica in funzione di un’originale archeologia delle moderne ovvietà, degli “apriori” culturali in cui siamo immersi.
I lettori appassionati di Illich vi troveranno cose nuove e inaspettate…
Ma soprattutto vi troveranno il contrario di quello che si pensa di lui.
Illich è un innamorato del presente. Altro che lontananza da esso.
La sua metodologia del distacco, che va dal registro geografico e antropologico a quello linguistico e storico, nasce da una ipersensitività al presente, una capacità di soffrirne e di essere attento ai suoi rivolgimenti che sbalordisce in un uomo che avanza negli anni (F. La Cecla).
“In the Vineyard of the Text. A Commentary to Hugh’s Didascalicon“, The University of Chicago Press, Chicago, 1993.
Trad. it. “Nella vigna del testo“, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1994.
La ‘cultura del libro’ (insieme alle tecniche di lettura ad essa associate, che per secoli hanno legittimato le istituzioni scolastiche occidentali) sta per volgere al termine.
Alla pagina e al libro sono subentrati lo schermo e i nuovi mezzi di ‘comunicazione’, che richiedono al lettore “habitus” e capacità differenti e ne modificano la percezione sociale.
Per meglio comprendere la transizione in corso, Illich si sofferma su di un’altra transizione, verificatasi nel dodicesimo secolo, allorché alla lettura monastica si sostituì la lettura ‘scolastica’, la cui eredità è giunta fino a noi.
Da pellegrinaggio nel non conosciuto, ricerca della saggezza mediante la decifrazione del significato della creazione, interpretata come libro gravido di senso, la lettura divenne gradualmente ricerca della conoscenza, tentativo di posseder e la natura attraverso la sua descrizione.
L’analisi di Illich (che si svolge come commentario al “Didascalicon” di Ugo di San Vittore, il primo libro dedicato all’arte di leggere) illustra un capitolo significativo della storia delle relazioni tra gli assiomi costitutivi della mentalità occidentale e le tecniche alfabetiche.
Il riconoscimento che la lettura libresca ‘classica’ è solo uno tra i tanti modi di utilizzo delle tecniche alfabetiche non è privo di conseguenze: esso può permetterci oggi di coltivare una molteplicità di approcci alla pagina che sotto il monopolio della lettura scolastica non hanno potuto fiorire.
Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..