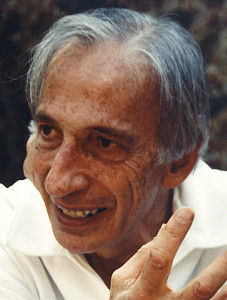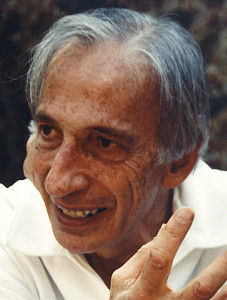
AG.RF.(redazione).23.02.2018
“riverflash” – L’egemonia dei bisogni attribuiti.
Le professioni non sarebbero mai diventate dominanti e menomanti se la gente non fosse stata pronta a sentire come una carenza ciò che l’esperto le attribuiva come ‘bisogno’.
Il rapporto di dipendenza reciproca che lega l’uno all’altra, come tutore a pupillo, non si riesce ormai più a scorgere perché oscurato dalla corruzione della lingua.
Certe buone vecchie parole si sono trasformate in etichette, che indicano a quali specialisti compete la tutela sulla casa, sulla bottega, sul negozio e sullo spazio o sull’aria che li separa.
La lingua, il più fondamentale dei beni comuni, è contaminata da contorti fili gergali, ognuno manovrato da una professione.
L’espropriazione delle parole, l’impoverimento del lessico quotidiano e la sua degradazione a terminologia burocratica corrispondono, in modo ancor più intimamente avvilente, a quella particolare forma di degradazione ambientale che toglie agli uomini la capacità di sentirsi utili se non hanno un impiego retribuito.
Finché non si presterà maggiore attenzione ai pervertimenti di vocabolario dietro cui si nasconde il dominio delle professioni, è quasi inutile proporre riforme di legge, di comportamenti e di modelli intese a restringere tale dominio.
Quando io ho imparato a parlare, non esistevano altri ‘problemi’ fuorché quelli di matematica o di scacchi; le ‘soluzioni’ erano saline o legali, e ‘bisogno’ era per lo più usato in forma verbale.
Espressioni come ho un problema oppure ho un bisogno suonavano alquanto bislacche.
Quand’ero adolescente, e mentre Hitler elaborava ‘soluzioni’, si diffusero anche i ‘problemi sociali’.
Varietà sempre nuove di ‘bambini con problemi’ venivano scoperte tra i poveri man mano che gli assistenti sociali imparavano a marchiare le loro prede e a standardizzarne i ‘bisogni’.
Il bisogno, inteso come sostantivo, fu la biada che fece espandere le professioni fino a instaurarne il dominio.
La povertà si venne modernizzando.
Da esperienza, i manager la tradussero in misura.
I poveri divennero i ‘bisognosi’.
Durante la seconda metà della mia vita, l’essere ‘bisognosi’ acquisì rispettabilità.
I bisogni calcolabili e imputabili salirono di grado nella scala sociale. ‘Aver bisogno’ cessò di essere un segno di povertà.
Il reddito originò nuove categorie di bisogni.
I pedocrati alla dottor Spock, i sessuocrati alla Lewis Comfort e i volgarizzatori di Ralph Nader che col pretesto di tutelare i consumatori stimolano il consumo, addestrarono i profani a procacciarsi soluzioni per i problemi che imparavano a inventarsi seguendo le istruzioni professionali.
Le università abilitarono i laureati a scalare vette sempre più aeree per piantarvi e coltivarvi sempre più nuove specie di bisogni ibridati.
Aumentarono le prescrizioni e si ridussero le capacità.
In medicina, per esempio, vennero prescritti prodotti farmacologicamente sempre più attivi, mentre la gente perdeva la voglia e la capacità di affrontare un’indisposizione o anche un semplice malessere.
Nei supermercati americani, dove si calcola che compaiano annualmente circa 1500 prodotti nuovi, meno del venti per cento di essi sopravvive per più di un anno su gli scaffali, mentre gli altri si rivelano invendibili, legati a mode effimere, rischiosi o non remunerativi, o subito superati da nuovi articoli; ragion per cui i consumatori sono sempre più indotti a cercare la guida dei professionisti della ‘difesa del consumatore’.
Il rapido ricambio dei prodotti, inoltre, rende i desideri vacui e informi.
Sicché, paradossalmente, un forte consumo di massa derivato da bisogni indotti genera nel consumatore una crescente indifferenza al desiderio specifico, vissuto.
Sempre di più i bisogni sono creati dallo slogan pubblicitario e dagli acquisti fatti su prescrizione del funzionario, dell’estetista, del ginecologo e di decine di altri diagnosti.
Il bisogno di essere istruiti sul modo di aver bisogno (mediante la pubblicità, la prescrizione o la discussione guidata nel collettivo o nella comune) compare in ogni cultura in cui le decisioni e gli atti non sono più la risultante di un’esperienza personale del soddisfacimento, e il consumatore flessibile non può che sostituire i bisogni sentiti con bisogni appresi.
Man mano che si progredisce nell’arte d’imparare a provare bisogni, la capacità di modellare i propri desideri in funzione di una personale ricerca di soddisfazione diventa una prerogativa rara, propria della gente molto ricca o di quella più diseredata.
Poiché d’altra parte i bisogni vengono incessantemente suddivisi in componenti sempre più piccole, ognuna gestita da un apposito specialista, diviene difficile per il consumatore integrare le disparate offerte dei suoi diversi tutori in una totalità che abbia senso, che possa essere desiderata con piena cognizione di causa e ottenuta con piacere.
Dall’alimentazione all’istruzione, dall’armonia coniugale all’inserimento sociale, dalla dietetica alla meditazione, dall’aggiornamento al riciclaggio, consulenti, esperti e altri personaggi del genere sono pronti a cogliere ogni nuova possibilità di gestire la gente e ad offrire i loro prodotti prefabbricati per appagare ogni bisogno parcellizzato.
Usato come sostantivo, ‘bisogno’ è la riproduzione su scala individuale di un modello professionale; è la copia in plastica della matrice nella quale i professionisti fondono i loro prodotti; è la forma pubblicitaria che assume il favo nel quale si generano i consumatori.
Ignorare i propri bisogni o dubitarne è diventato un comportamento sociale inammissibile.
Buon cittadino è colui che attribuisce a se stesso bisogni standardizzati, con tanta convinzione da soffocare ogni altro possibile desiderio e, a maggior ragione, ogni eventuale idea di rinuncia.
Quando sono nato io, prima che Stalin, Hitler e Roosevelt salissero al potere, soltanto i ricchi, gli ipocondriaci e gli appartenenti ad alcune categorie d’élite affermavano d’aver bisogno di assistenza medica quando avevano qualche linea di febbre.
I medici di allora, a questo riguardo, non disponevano di rimedi molto diversi d a quelli delle nonne.
La prima mutazione dei bisogni, in medicina, si ebbe con i sulfamidici e gli antibiotici.
Mentre si potevano ormai stroncare le infezioni in modo semplice ed efficace, i farmaci idonei furono sempre più soggetti a prescrizione medica.
I medici ebbero il monopolio dell’assegnazione del ruolo di malato.
Chi non si sentiva bene doveva andare dal medico a farsi etichettare con il nome di una malattia, che legittimava la sua inclusione nella minoranza dei cosiddetti malati: individui esentati dal lavoro, autorizzati a ricevere assistenza, sottoposti agli ordini del medico e tenuti a guarire per tornare ad essere utili.
Paradossalmente, proprio mentre la tecnica farmacologica, analisi e medicinali, diventava talmente automatica e poco costosa che si sarebbe potuto fare a meno del medico, la società emanava leggi e regolamenti di polizia intesi a limitare il libero uso di quei procedimenti che la scienza aveva semplificato e a riservarli esclusivamente ai professionisti.
La seconda mutazione dei bisogni avvenne quando i malati cessarono di essere una minoranza.
Oggi sono ben pochi coloro che riescono a scansare a lungo la prestazioni mediche.
In Italia come negli Stati Uniti, in Francia o in Belgio, un cittadino su due è sorvegliato contemporaneamente da vari specialisti della salute, che lo curano, lo consigliano o, come minimo, lo tengono sotto osservazione.
L’oggetto di questa assistenza specialistica è il più delle volte uno stato (dei denti, dell’utero, del sistema nervoso, della pressione sanguigna o dell’attività ormonica) di cui il ‘paziente’ non patisce.
Sicché oggi non sono più i pazienti a costituire la minoranza, ma quei devianti che in qualche modo restano fuori da tutte le classi di pazienti.
Compongono tale minoranza i poveri, i contadini, gli immigrati recenti e vari altri che, talvolta di propria volontà, si sottraggono agli obblighi del servizio sanitario.
Ancora una ventina d’anni fa ‘non vedere mai un medico’ era segno di salute normale, che si presumeva buona; oggi una simile condizione di non paziente denota miseria o dissenso.
E’ cambiata persino la figura dell’ipocondriaco.
Il medico degli anni Quaranta definiva con questo termine colui che bussava continuamente alla porta del suo studio, il malato immaginario.
I medici d’oggi invece indicano col medesimo nome la minoranza che li fugge: gli ipocondriaci sono i sani immaginari.
Essere inseriti in un sistema professionale come clienti a vita non è più uno stigma che separa gli individui menomati dalla massa dei cittadini.
Viviamo in una società organizzata in funzione delle maggioranze devianti e dei loro custodi.
Essere attivo cliente di parecchi professionisti ti dà un posto ben definito in quel regno dei consumatori intorno al quale ruota la nostra società.
Trasformandosi da professione liberale consultiva in professione dominante e menomante, la medicina ha così incommensurabilmente accresciuto il numero dei bisognosi.
A questo punto critico, i bisogni attribuiti subiscono una terza mutazione.
Si saldano in quello che gli esperti chiamano un problema multidisciplinare, il quale perciò richiede una soluzione multiprofessionale.
Prima la proliferazione delle merci, ciascuna tendente a diventare una necessità, ha efficacemente addestrato il consumatore a provare bisogni a comando.
Poi la graduale parcellizzazione dei bisogni in spezzoni sempre più piccoli e distinti ha portato il cliente a dipendere dal giudizio dell’esperto per poter miscelare i propri bisogni in un insieme significativo.
Ne offre un buon esempio l’industria dell’automobile.
Dalla fine degli anni Sessanta il numero degli accessori facoltativi reclamizzati come necessari per ‘personalizzare’ una Ford di serie è immensamente cresciuto; ma contrariamente a quel che si aspetterebbe il cliente, questa paccottiglia ‘opzionale’ viene in realtà montata sulla catena di montaggio dello stabilimento di Detroit, e all’acquirente del Montana non resta che scegliere tra i pochi modelli già completi di tutto che vengono spediti a caso: se vuole la decappottabile deve prenderla con i sedili verdi che detesta, mentre se per le sue conquiste non può fare a meno dei sedili in finto leopardo deve adattarsi a una berlina col tetto rigido foderato in stoffa scozzese.
Infine il cliente viene educato ad aver bisogno delle prestazioni di un’intera équipe per poter ricevere un’assistenza soddisfacente’, come dicono i suoi tutori.
E’ ciò che accade quando i servizi professionali si rivolgono individualmente al singolo consumatore, allo scopo di migliorarne lo stato.
Sono tanti ormai coloro che passano l’intera esistenza in un dedalo di terapie che secondo i servizi assistenziali dovrebbero servire a migliorare la loro vita.
Più si sviluppa l’economia dei servizi, meno tempo resta all’individuo per consumare l’assistenza pedagogica, medica, sociale, eccetera.
La scarsità di tempo potrebbe diventare presto il principale ostacolo al consumo dei servizi prescritti dai professionisti e spesso pagati dalla collettività.
E’ una scarsità che comincia a manifestarsi assai presto.
Già nella scuola materna il bambino viene preso in carico da tutto un gruppo di specialisti: l’allergista, il foniatra, il pediatra, lo psicologo dell’infanzia, l’assistente sociale, l’esperto di educazione psicomotoria, la maestra.
Costituendo questa équipe pedocratica, i numerosi e vari professionisti tentano di dividersi quel tempo che è diventato il principale limite all’attribuzione di ulteriori bisogni.
Per l’adulto, il luogo dove si concentra la somministrazione dei servizi è il post o di lavoro: dal direttore del personale a quello della formazione, dallo psicologo al medico all’assistente sociale al produttore di assicurazioni, tutti questi specialisti trovano più redditizio spartirsi di comune accordo il tempo del lavoratore che disputarselo singolarmente.
Un cittadino senza bisogni sarebbe fortemente sospetto.
La gente ha bisogno d’un impiego, si dice, per l’assistenza che garantisce prima ancora che per i soldi.
Sparisce la comunità, sostituita da una nuova placenta composta di tubi che erogano assistenza professionale.
Sottoposta a cure intensive permanenti, la vita si paralizza.
3. Alcune distinzioni riabilitanti.
La menomazione che, con l’egemonia delle professioni, colpisce il cittadino è consolidata dalla potenza dell’illusione.
Le speranze di salvezza un tempo riposte nelle credenze religiose cedono il posto a una fiduciosa attesa nei confronti dello Stato, supremo dispensatore di servizi professionali.
Ognuno dei molteplici cleri accampa la propria competenza a definire le difficoltà della gente in termini di specifici problemi risolvibili attraverso una qualche prestazione di servizi.
Nel momento in cui si riconosce tale pretesa, il profano è legittimato ad accettar e docilmente le carenze che gli vengono imputate, e il suo mondo si trasforma in una cassa di risonanza dei bisogni.
Il soddisfacimento delle scelte autonomamente definite e perseguite viene sacrificato all’appagamento di bisogni indotti.
Basta osservare il profilo delle nostre città per vedervi riflesso questo dominio dei bisogni fabbricati e amministrati: giganteschi edifici adibiti a servizi professionali incombono su masse di persone che fanno la spola tra l’uno e l’altro in un ininterrotto pellegrinaggio alle nuove cattedrali della salute, dell’istruzione e dell’esistenza.
Le case ‘sane’ in queste città sono quegli appartamenti asettici dove uno non può né nascere né star malato né morire decentemente.
Il vicino soccorrevole è una specie in via di estinzione, come il medico disposto a fare visite a domicilio.
Spariscono i luoghi di lavoro propizi all’apprendistato, sostituiti da opachi dedali di corridoi dove l’accesso è consentito solo ai dipendenti che portino appuntato al bavero della giacca il proprio ‘documento d’identità aziendale’ in plastica.
La città di questa popolazione tramutata in soggetto di assistenza è un mondo dove tutto è organizzato in funzione dell’erogazione di servizi.
La dipendenza dai bisogni imputabili, che è ormai predominante fra i popoli ricchi e che esercita un fascino paralizzante sui poveri, sarebbe sicuramente irreversibile se tra gli uomini e i ‘bisogni’ ad essi attribuiti esistesse una reale corrispondenza.
Ma non è così.
Al di là d’un certo grado d’intensità, la medicina produce impotenza e malattia; l’istruzione diventa il massimo generatore di una divisione menomante del lavoro; i sistemi di trasporto veloce trasformano gli abitanti delle città in passeggeri per circa un sesto delle loro ore di veglia, e per un altro sesto in forzati che lavorano per pagare Agnelli, la Esso e la società delle autostrade.
La soglia oltre la quale la medicina, l’istruzione e i trasporti diventano strumenti controproducenti è stata raggiunta in tutti i paesi del mondo che abbiano un livello di reddito pro capite almeno pari a quello di Cuba.
In tutti questi paesi, contrariamente alle illusioni diffuse dalle ideologie ortodosse, vuoi d’Occidente vuoi d’Oriente, tale controproduttività specifica non ha nulla a che fare con il tipo di scuola, di veicolo o di organizzazione sanitaria attualmente in uso: si sviluppa infatti ogni volta che, nel processo di produzione, l’intensità di capitale supera una certa soglia critica.
Le nostre principali istituzioni hanno acquisito il misterioso potere di ribaltare le finalità per le quali erano state originariamente concepite e sono finanziate.
Sotto la guida delle professioni più prestigiose, i nostri strumenti istituzionali ottengono come loro principale prodotto una paradossale controproduttività: la sistematica menomazione dei cittadini.
Una città imperniata sullo scorrimento a motore diventa inadatta per le gambe, e non c’è aumento del numero delle ruote che possa rimediare alla forzata immobilità de gli arti, resi paralitici.
Il sovrappiù di merci e di servizi paralizza l’azione autonoma.
Non ne deriva però soltanto una perdita secca delle soddisfazioni non compatibili con l’era industriale: l’incapacità di produrre valori d’uso finisce col rendere inefficaci e controindicati gli stessi prodotti che avrebbero dovuto surrogarli.
L’automobile, il sistema sanitario, la scuola, il “management” si tramutano allora in perniciose nocività per il consumatore e non arrecano più alcun beneficio se non a chi fornisce i servizi.
Perché allora non ci si ribella a questo moto di deriva della società industriale avanzata, che la porta a compattarsi in un unico sistema di erogazione di servizi?
La spiegazione principale sta nel potere, che tale sistema possiede, di generare illusioni.
Oltre a compiere atti concreti sui corpi e sulle menti, le istituzioni professionalizzate funzionano anche come potenti rituali, generatori di fede nelle cose che i loro gestori promettono.
Oltre a insegnare a Pierino a leggere, le scuole gli insegnano anche che imparare dai professori è ‘meglio’ e che, senza l’obbligo scolastico, i poveri leggerebbero meno libri.
Oltre a servire come mezzo di locomozione, l’autobus, non meno dell’auto privata, rimodella l’ambiente e bandisce l’uso delle gambe.
Oltre ad aiutare a evadere il fisco, i consulenti legali inculcano l’idea che le leggi risolvano i problemi.
Una parte sempre crescente delle funzioni svolte dalle nostre maggiori istituzioni consiste nel coltivare e rafforzare tre specie di illusioni, per effetto delle quali il cittadino si tramuta in un cliente che attende la propria salvezza unicamente dall’opera degli esperti.
Congestione e paralisi.
La prima illusione asservitrice è l’idea che l’uomo nasca per consumare e che possa raggiungere qualunque scopo acquistando beni e servizi.
Questa illusione deriva da una coltivata cecità riguardo all’importanza che hanno i valori d’uso nel quadro di un’economia.
In nessuno dei modelli economici oggi seguiti è prevista una variabile che tenga conto dei valori d’uso non negoziabili, e neanche una variabile che consideri il perenne apporto della natura.
E tuttavia non c’è sistema economico che non crollerebbe di colpo qualora la produzione dei valori d’uso si contraesse oltre un certo limite: per esempio se le faccende domestiche fossero svolte dietro retribuzione o se si facesse l’amore sol tanto a pagamento.
Ciò che la gente compie o fabbrica senza alcuna intenzione o possibilità di farne commercio è altrettanto incommensurabile e inestimabile per il mantenimento di un sistema economico quanto l’ossigeno che essa respira.
L’illusione che i modelli economici possano ignorare i valori d’uso nasce dalla convinzione che quelle attività che noi designiamo con verbi intransitivi si posso no sostituire indefinitamente con dei prodotti predisposti da istituzioni e che si indicano con un sostantivo: ‘I’istruzione’ al posto di ‘io apprendo’, ‘I’assistenza sanitaria’ per ‘io guarisco’, ‘i trasporti’ per ‘io mi muovo’, ‘Ia televisione’ per ‘io mi diverto’.
La confusione tra valori personali e valori standardizzati si è diffusa in quasi tutti i campi.
Sotto l’impero delle professioni, i valori d’uso si dissolvono, diventano obsoleti e finiscono col perdere il loro carattere specifico.
L’amore e l’assistenza istituzionale appaiono concetti interscambiabili.
Dieci anni di concreta conduzione di un podere, gettati in un frullatore pedagogico, risultano equivalenti a un diploma d’istituto tecnico.
Cose raccolte a caso e nate nella libertà della strada vengono aggiunte a titolo di ‘esperienza educativa’ a quelle versate nella testa degli allievi.
Sembra che i contabili del sapere non si rendano conto che le due cose, come l’olio e l’acqua, si mescolano solo finché le emulsiona la tipica mentalità dell’educatore’.
Ma se noi per primi non fossimo affascinati da questa sorta di avida credenza, le bande degli zelanti creatori di bisogni non potrebbero continuare a tartassarci e a profondere le nostre risorse nei loro esperimenti, nelle loro reti e nelle altre loro miracolose soluzioni.
L’utilità delle merci, ovvero dei beni e servizi di serie, è soggetta a due limiti intrinseci, che non vanno confusi tra loro.
Un limite è che prima o poi le code bloccheranno il funzionamento di ogni sistema che genera bisogni a ritmo più rapido dei prodotti destinati ad appagarli; l’altro è che prima o poi la dipendenza dalle merci condizionerà in tal modo i bisogni da paralizzare ogni capacità di produzione autonoma nel campo in questione.
L’utilità delle merci ha cioè i suoi limiti nella “congestione” e nella “paralisi”.
Entrambe sono risultati del supersviluppo in qualunque campo di produzione, ma di tipo molto diverso fra loro.
La congestione, che mostra sino a che punto le merci possano diventare d’impacci o a se stesse, spiega perché l’auto privata non è più di alcuna utilità per spostarsi in Manhattan; però non spiega perché la gente si ammazzi dal lavoro per pagare le rate e i premi d’assicurazione per automobili che non servono a spostarla.
E ancora meno la congestione, da sola, spiega perché la gente arrivi a dipendere dai veicoli in misura tale da finire paralizzata e non saper più usare le proprie gambe.
Se la gente diventa prigioniera di un’accelerazione che consuma tempo, di un’istruzione che inebetisce e di una medicina che rovina la salute è perché, oltre una certa soglia d’intensità, la dipendenza da una lista di beni industriali e di servizi professionali distrugge le potenzialità umane, in una maniera tutta specifica.
Solo fino a un certo punto le merci possono sostituire ciò che la gente compie o fabbrica per conto proprio.
Solo entro certi limiti i valori di scambio possono rimpiazzare soddisfacentemente i valori d’uso.
Al di là di tale soglia, ogni ulteriore produzione di merci arreca beneficio solo al produttore professionale, che ne imputa il bisogno al consumatore, mentre lascia il consumatore stordito e disorientato, anche se più fornito.
Il piacere che si prova non nel mero pagamento ma nella soddisfazione di un bisogno è connesso in misura significativa al ricordo di un’azione personale autonoma; esistono dei limiti oltre i quali la proliferazione delle merci altera nel consumatore proprio questa facoltà di realizzarsi agendo.
Nel ricevere unicamente prodotti bell’e fatti, che non lasciano alcun margine di azione da parte sua, il consumatore non può che restarne paralizzato.
La misura del benessere di una società non è mai pertanto un’espressione algebrica nella quale i due modi di produzione, l’autonomo e l’eteronomo, si equivalgono, bensì sempre un equilibrio che si ha quando i valori d’uso e le merci si combinano in fruttuosa sinergia.
Solo fino a un certo punto la produzione eteronoma di una merce può valorizzare e integrare la realizzazione autonoma del fine personale corrispondente; superato tale punto, la sinergia tra i due modi di produzione si rivolge paradossalmente contro lo scopo a cui miravano sia il valore d’uso sia la merce.
E’ un fatto, questo, che talvolta non viene percepito perché il movimento ecologico, nella sua principale espressione, tende a far perdere di vista il punto.
L’opposizione alle centrali nucleari, per esempio, è stata generalmente motivata col pericolo delle radiazioni o col rischio di un’eccessiva concentrazione di potere nelle mani dei tecnocrati: ma ben di rado, finora, si è osato criticarle per i l loro apporto alla già eccessiva quantità di energia disponibile.
Misconoscendo il fatto che tale sovrabbondanza di energia è socialmente distruttiva in quanto paralizza l’azione dell’uomo, si continua a reclamare una produzione energetica semplicemente “diversa” anziché, come si dovrebbe, “minore”.
Allo stesso modo sono ancora largamente ignorati gli inesorabili limiti alla crescita che sono insiti in qualunque ente erogatore di servizi; eppure dovrebbe essere ormai evidente che l’istituzionalizzazione della cura della salute tende a trasformare le persone in marionette malate e che l’educazione a vita non può che generare una cultura buona per gente programmata.
L’ecologia potrà fornire un punto di riferimento nel cammino verso una forma di modernità vivibile solo quando ci si renderà conto che un ambiente modellato dall’uomo in funzione delle merci riduce a tal punto le reattività dell’individuo che le merci stesse perdono qualsiasi valore come mezzo di soddisfazione personale.
Senza questa consapevolezza, può accadere che grazie ad una tecnologia industriale più pulita e meno aggressiva si raggiungano livelli di opulenza frustrante oggi inconcepibili.
Sarebbe sbagliato attribuire la controproduttività essenzialmente alle ‘esternalità’ dello sviluppo economico, quali il depauperamento delle risorse, l’inquinamento e le varie forme di congestione.
Ciò significherebbe confondere la congestione, per cui le cose si intralciano fra loro, con la paralisi della persona che non può più esercitare la propria autonomia in un ambiente fatto per le cose.
La ragione fondamentale, per cui un’elevata intensità di mercato porta inesorabilmente alla controproduttività, va vista nel tipo di monopolio che le merci esercita no sulla formazione dei bisogni umani.
Tale monopolio supera di gran lunga ciò che s’intende di solito con questo termine.
Un monopolio commerciale si limita a imporre al mercato una determinata marca di whisky o di automobili.
Un cartello industriale può restringere ulteriormente la libertà, per esempio appropriandosi di tutti i mezzi di trasporto collettivo per favorire lo sviluppo della motorizzazione privata, come fece la General Motors comprando i tram di Los Angeles.
Al primo si può sfuggire bevendo rum, al secondo girando in bicicletta.
Tutt’altra cosa è invece quello che io definisco col termine ‘monopolio radicale’, e che consiste nella sostituzione di un prodotto industriale o di un servizio professionale a un’attività utile cui la gente si dedica o vorrebbe dedicarsi.
Un monopolio radicale paralizza l’attività autonoma, a vantaggio della prestazione professionale.
Più i veicoli dislocano la gente, più diventa necessario l’intervento di regolatori del traffico e più la gente perde la facoltà di tornarsene a casa a piedi.
Quand’anche i motori fossero alimentati con energia solare e i veicoli fossero fatti d’aria, questo monopolio radicale continuerebbe a sussistere essendo inseparabile dalla circolazione ad alta velocità.
Più a lungo una persona resta sotto la cappa del sistema educativo, meno avrà tempo e voglia di curiosare e di riflettere criticamente.
In qualunque campo, a un certo punto l’abbondanza dei beni offerti al consumo rende l’ambiente così inadatto all’azione personale che l’eventuale sinergia tra i valori d’uso e le merci diventa negativa.
Si instaura allora una controproduttività paradossale, specifica.
E’ questo il termine col quale io definisco tutti i casi in cui l’impotenza conseguente alla sostituzione di un valore d’uso con una merce tramuta quest’ultima in un disvalore ai fini di quella soddisfazione che dovrebbe fornire.
Strumenti industriali e strumenti conviviali.
L’uomo cessa di essere riconoscibile come tale quando non è più in grado di dar forma ai propri bisogni mediante l’uso più o meno abile degli strumenti che gli sono forniti dalla sua cultura.
Per tutto il corso della storia, questi strumenti sono stati per lo più attrezzi ad alta intensità di lavoro, adoperabili per procurare soddisfazione a chi se ne serviva, e che venivano impiegati per una produzione domestica; solo marginalmente le pale e i martelli venivano usati per altri scopi, quali potevano essere la costruzione di una piramide, la fabbricazione di un sovrappiù destinato allo scambio di doni, o, ancor meno di frequente, la produzione di beni da vendere.
Le occasioni di ricavare profitti erano limitate; si lavorava soprattutto per creare valori d’uso non destinati allo scambio.
Ma il progresso tecnologico è stato tenacemente applicato alla realizzazione di un tutt’altro tipo di strumento: uno strumento volto in primo luogo a produrre merci vendibili.
Si cominciò con la rivoluzione industriale, quando la nuova tecnologia ridusse il lavoratore al robot chapliniano di “Tempi moderni”.
In questa prima fase, però, il modo di produzione industriale non arrivava ancora a paralizzare la gente fuori del luogo di lavoro.
Gli uomini e le donne d’oggi, invece, che ormai dipendono quasi in tutto dalla distribuzione di frammenti standardizzati prodotti mediante strumenti azionati da altra gente anonima, non trovano più nell’uso degli strumenti quella soddisfazione diretta, personale, che ha stimolato l’evoluzione dell’umanità e delle sue culture.
Mentre i loro bisogni e i loro consumi si sono moltiplicati di molte volte rispetto al passato, è diventata rara fra loro la soddisfazione nel maneggio degli strumenti, ed essi non vivono più quella vita in funzione della quale ha preso forma il loro organismo.
Nel migliore dei casi sono ridotti a sopravvivere, pur se circondati di sfarzo.
Il corso della loro esistenza è diventato una catena di bisogni, di volta in volta saziati al fine di suscitare nuovi bisogni e la necessità di appagarli.
Con questa riduzione dell’uomo a consumatore passivo, si finisce col perdere per sino il senso della differenza fra il vivere e il sopravvivere.
Al gusto della vita si sostituisce la scommessa dell’assicurazione, la trepida attesa di razioni e terapie.
In un simile ambiente diventa facile dimenticare che soddisfazione e gioia possono aversi solo sin quando, nel proseguimento di un fine, vitalità personale e provvidenze tecniche restino in equilibrio.
L’idea che gli strumenti di cui si servono le istituzioni di mercato possono distruggere impunemente le condizioni che permettono l’uso personale di mezzi conviviali è un’illusione, che riesce a soffocare ogni ‘vitalità’ presentando il progresso tecnologico come un fatto che autorizza e impone un sempre maggior dominio delle professioni.
Questa illusione induce a credere che gli strumenti, per acquisire efficacia nel perseguimento di un fine specifico, non possano che diventare sempre più complessi e arcani, come per esempio le cabine di guida degli aerei o le gru.
Si pensa perciò che gli strumenti moderni richiedano necessariamente operatori speciali, dotati d’un elevatissimo addestramento, e che soltanto in questi operatori si possa riporre piena fiducia.
In realtà, di solito è vero proprio il contrario, e per forza.
Quanto più le tecniche si moltiplicano e accrescono la loro specificità, tanto meno complessa diventa, spesso, la valutazione che presiede al loro impiego.
Neppure la fiducia del cliente, sulla quale si fondava l’autonomia del libero professionista come anche dell’artigiano, è più richiesta.
Per quanti passi avanti la medicina abbia fatto, rispetto al totale degli atti medici sono soltanto una minuscola frazione quelli che richiedono, a una persona di media intelligenza, una preparazione particolarmente sviluppata.
Da un punto di vista sociale, il titolo di ‘progresso tecnico’ dovrebbe essere riservato ai casi in cui nuovi strumenti accrescano la capacità e l’efficienza di una più vasta massa di persone, e in particolare permettano una più autonoma produzione di valori d’uso.
Il monopolio professionale che si estende sulla nuova tecnologia non è affatto inevitabile.
Le grandi invenzioni dell’ultimo secolo, quali i nuovi metalli, i cuscinetti a sfera, certi materiali da costruzione, l’elettronica, certi procedimenti di analisi e certi medicamenti, sono suscettibili di accrescere il potere di entrambi i modi di produzione, di quello eteronomo come di quello autonomo.
Di fatto però la nuova tecnologia non è stata per lo più incorporata nella strumentazione conviviale, ma in confezioni e in complessi istituzionali.
Messa pressoché costantemente al servizio della produzione industriale, grazie alla sua indubbia capacità di recare vantaggio a chi la gestisce la tecnologia ha consentito ai professionisti di instaurare un monopolio radicale.
La controproduttività indotta dalla paralisi nella produzione di valori d’uso trova incremento in questo modo di concepire il progresso tecnologico.
Non esiste alcun ‘imperativo tecnologico’ che, di per sé, imponga che i cuscinetti a sfera vengano impiegati nei veicoli a motore o che l’elettronica venga usata per controllare il funzionamento del cervello.
Le istituzioni in cui si traducono il traffico ad alta velocità o la tutela della salute mentale non sono “conseguenze necessarie” del cuscinetto a sfere o del circuito elettronico; le loro funzioni sono determinate dai bisogni che si presume dovrebbero soddisfare: bisogni che, in grandissima misura, sono definiti, imputati e rafforzati dalle professioni menomanti.
E’ questo un punto che sembra sfuggire ai giovani turchi radicali attivi nelle professioni allorché essi giustificano la propria fedeltà alle istituzioni presentandosi come sacerdoti investiti dal popolo della missione di addomesticare il progresso tecnologico.
La medesima soggezione a tale idea del progresso fa sì che la progettazione sia in tesa soprattutto come un contributo all’efficienza delle istituzioni.
Alla ricerca scientifica si destinano abbondanti finanziamenti, ma solo se può essere applicata a scopi militari o se serve a consolidare il dominio professionale.
Le leghe metalliche che permettono di fabbricare biciclette più robuste e leggere sono un frutto indiretto di studi orientati alla produzione di aviogetti più veloci e di armi più micidiali.
Ma i risultati della ricerca si riversano quasi esclusivamente sull’attrezzatura industriale, sicché macchine già enormi diventano ancora più complesse e imperscrutabili per il profano.
Da questo orientamento cui si ispirano scienziati e tecnici esce rafforzata una tendenza già pesante: i bisogni che richiedono un’attività autonoma vengono misconosciuti, mentre si moltiplicano quelli che comportano l’acquisto di merci.
Gli strumenti conviviali che facilitano il godimento individuale dei valori d’uso, e che richiedono poca o punta supervisione amministrativa, medica o poliziesca, non trovano più posto che ai due estremi: nella maggior parte del mondo, ormai, le due sole categorie di persone che vanno in bicicletta sono i lavoratori poveri dell’Asia e gli studenti e i professori dei paesi ricchi.
Forse senza rendersi conto della propria fortuna, gli uni e gli altri si godono la libertà da questa seconda illusione.
Da qualche tempo, certi gruppi di professionisti, alcuni enti governativi e organizzazioni internazionali si sono messi a studiare, elaborare e caldeggiare una tecnologia intermedia, su piccola scala.
Si potrebbe pensare che questi sforzi siano volti a eliminare le più smaccate sconcezze dell’imperativo tecnologico.
Ma, in grandissima parte, questa nuova tecnologia intesa a consentire che la gente faccia da sé nel campo della salute, dell’istruzione, della costruzione delle case, non è che un diverso modello di offerta di merci ad alta intensità di dipendenza.
Si chiede per esempio agli esperti di progettare un nuovo tipo di armadietto per medicinali che permetta alle famiglie di seguire le direttive impartite dal medico via telefono.
Si insegna alle donne a esaminarsi da sole il seno al fine di dar lavoro al chirurgo.
Ai cubani si danno ferie pagate perché possano montarsi in proprio le case prefabbricate prodotte in serie dall’industria.
L’allettante prestigio dei prodotti professionali finisce, man mano che si abbassa il loro costo, col rendere ricchi e poveri sempre più simili tra loro.
Tanto i boliviani quanto gli svedesi si sentono ugualmente arretrati, diseredati e sfruttati nella misura in cui imparano senza la supervisione di professori, stanno in buona salute senza il check-up di un medico e si muovono senza l’ausilio di una stampella motorizzata.
Libertà e diritti.
La terza illusione menomante consiste nell’affidare agli esperti l’incarico di fissare un limite alla crescita.
Si suppone che intere popolazioni, socialmente condizionate a provare bisogni a comando, non attendano altro che di sentirsi dire di che cosa non hanno bisogno.
Gli stessi agenti multinazionali che per una generazione hanno imposto ai ricchi come ai poveri un modello internazionale di contabilità, di deodorante, di consumo d’energia, patrocinano ora il Club di Roma.
Docilmente l’Unesco si accoda e addestra specialisti nell’imputazione di bisogni su scala regionale.
Così, in nome del loro presunto bene, i ricchi vengono programmati a sobbarcarsi nei propri paesi un dominio professionale più costoso, e a riconoscere ai poveri bisogni di tipo più economico e frugale.
I più intelligenti dei nuovi professionisti sanno benissimo che la penuria crescente porterà a una sempre maggior accentuazione dei controlli sui bisogni: non a caso l’impiego più prestigioso, oggigiorno, è la pianificazione centralizzata del decentramento ottimale della produzione.
Ma il fatto di cui ancora non ci si rende conto è che attendersi la salvezza da una limitazione decretata dai professionisti significa fare confusione tra libertà e diritti.
In ognuna delle sette regioni in cui l’Onu ha diviso il mondo si sta addestrando un nuovo clero destinato a predicare il particolare stile d’austerità disegnato d ai nuovi progettisti di bisogni.
Specialisti in ‘presa di coscienza’ battono le comunità locali incitando la gente a raggiungere gli obiettivi di produzione decentrata che le sono stati assegnati.
Mungere la capretta di famiglia era una libertà fino a quando una pianificazione più spietata non ne ha fatto un dovere, per contribuire al P.N.L.
La sinergia tra produzione autonoma e produzione eteronoma si rispecchia nell’equilibrio che una società mantiene tra libertà e diritti.
Le libertà proteggono i valori d’uso come i diritti tutelano l’accesso alle merci.
E come le merci possono distruggere la possibilità di creare valori d’uso e tramutarsi in ricchezza depauperante, così la definizione professionale dei diritti può soffocare le libertà e instaurare una tirannide che seppellisce la gente sotto i suo i diritti.
La confusione appare particolarmente evidente se pensiamo agli esperti della salute.
La salute comprende due aspetti: libertà e diritti.
Essa designa quella zona di autonomia entro la quale una persona governa i propri stati biologici e le condizioni del proprio ambiente immediato.
In parole povere, la salute s’identifica con il grado di libertà vissuta.
Di conseguenza, coloro che si occupano del bene pubblico dovrebbero adoperarsi a garantire un’equa distribuzione della salute come libertà, che a sua volta dipende da condizioni ambientali realizzabili soltanto con interventi politici organizzati.
Oltre una certa soglia d’intensità, l’assistenza sanitaria professionale, per equamente distribuita che sia, non può che soffocare la salute in quanto libertà.
In questo senso fondamentalmente la cura della salute è una questione di adeguata salvaguardia della libertà.
Un siffatto concetto della salute implica, è evidente, un rispetto di principio delle libertà inalienabili.
Per ben comprendere questo punto, occorre distinguere chiaramente tra libertà civile e diritti civili.
La libertà di agire senza che l’autorità frapponga ostacoli ha una portata più vasta dei diritti civili che lo Stato può promulgare per garantire a ognuno uguali possibilità di ottenere certi beni e servizi.
Di regola le libertà civili non costringono gli altri ad agire secondo i desideri di terzi.
Io sono libero di parlare e di rendere pubbliche le mie opinioni, ma nessun giornale è obbligato a stamparle e nessuno dei miei concittadini è tenuto a leggerle.
Io sono libero di dipingere la bellezza così come pare a me, ma nessun museo ha l’obbligo di comprare i miei quadri.
Contemporaneamente però lo Stato, quale garante della libertà, può emanare ed emana le ggi che proteggano quell’uguaglianza dei diritti senza la quale i suoi membri non potrebbero godere delle proprie libertà.
Tali diritti danno un senso e una realtà all’uguaglianza, mentre le libertà danno possibilità e forme alla libertà.
Un modo sicuro per sopprimere le libertà di parlare, d’imparare, di guarire, di curare, è quello di delimitarle trasformando i diritti civili in doveri civili.
La terza illusione consiste appunto nel credere che la rivendicazione pubblica dei diritti porti senz’altro a salvaguardare le libertà.
Di fatto, quanto più una società affida ai professionisti l’autorità legale di definir e i diritti, tanto più le libertà dei cittadini si dissolvono.
Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..